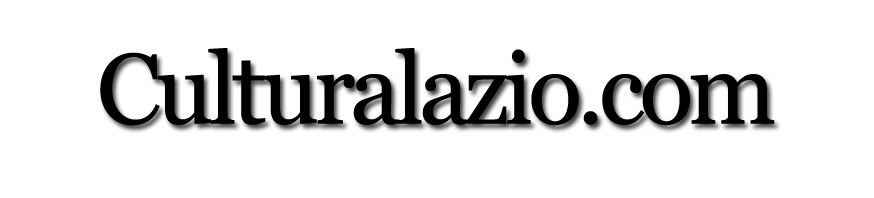Recensione dello spettacolo “Cloture de l’amour” a cura di Valerio Azzopardi.
Cloture de l’amour, la violenza dell’amore, un opera di Pascal Rambert in scena al Teatro Vascello.
Un dialogo sulla fine di un amore; un addio interpretato da due soli attori: Anna De Rosa e Luca Lazzareschi. Due monologhi in realtà, perché le parole dei due protagonisti non s’incroceranno mai.Un uomo e una donna s’incontrano sul palco; In piedi, l’uno di fronte all’altro, si affrontano. E’ l’uomo a cominciare riversando sulla donna un fiume ininterrotto di parole; una piena che sembra non trovare resistenza nella donna le cui uniche reazioni saranno qualche movimento del corpo e il proprio silenzio. Poi sarà quest’ultima a difendersi dalle accuse riversando a sua volta il proprio veleno.
Chi non ha mai detto addio? Chi non hai mai visto terminare un amore? E il veleno che ne consegue inevitabile, le recriminazioni, la violenza verbale, l’ansia di avere ragione dimostrando l’altrui torto, il desiderio di mostrare le proprie ferite interiori come uniche o principali vittime del massacro dell’amore.
Un’opera essenziale, ridotta all’osso: La scena è bianca, vuota e accecante, non ci sono musiche o giochi di luci, il movimento è quasi inesistente, ma è chiara la scelta stilistica di rendere unici protagonisti del dramma i due monologhi e l’effetto che questi hanno sui corpi degli attori.
La recitazione dei due protagonisti è buona, a tratti intensa (si avverte un progressivo fervore che scalda le voci dei due attori e che rende la narrazione più credibile col passare del tempo).
Quello che invece non si sopporta (secondo la mia opinione personale) è l’incredibile logorrea che sta alla base di tutto il dramma: Un addio di una verbosità così accecante da lasciare senza parole la donna (che si vendicherà con altrettanta potenza verbale) e anche il pubblico.
Quest’ampollosità eccessiva allontana lo spettatore dallo spettacolo, rendendo difficile ogni riflessione sulla vicenda e la comprensione della stessa. Comprensione già resa difficile dal fatto che l’opera ci fa assistere alla fine di una storia d’amore di cui non abbiamo esperienza pregressa, sfidandoci a capirne le motivazioni.
Ogni volta che una frase, o un concetto appare interessante esso viene sommerso da ripetizioni, allitterazioni e sinonimi in ridondanza così eccessiva da compromettere seriamente la comprensione, da annoiare e innervosire. L’uomo sembra fiero della propria retorica, cosa che la donna gli rinfaccerà, combattendo però a sua volta con le sue stesse noiose armi.
E proprio a causa della distanza dialettica da un qualunque possibile addio due esseri umani potranno mai rivolgersi, i due monologhi finiscono per diventare surreali, rendendo difficile una possibile immedesimazione da parte dello spettatore. La scelta del monologo come tecnica narrativa inoltre non fa altro che allontanare dalla comprensione il già lontano spettatore a cui è richiesto di ricordare le elucubrazioni mentali della prima parte per poter meglio capire la difesa a tali accuse nella seconda. A questo si aggiunge un’acustica non proprio eccezionale dello spettacolo che, non prevedendo microfoni, rende a tratti quasi inudibili le parole. (ho sentito più volte degli spettatori chiedere al proprio vicino che cosa era stato appena detto, e non ero seduto neppure nelle ultime file).
Quasimodo, poeta del novecento sosteneva che la poesia è come un messaggio in bottiglia. L’importanza sta naturalmente nel messaggio, ma senza la bottiglia (La prosa, il linguaggio, la forma) esso non arriverà mai al destinatario. E il linguaggio usato da “Cloture de l’amour” allontana lo spettatore, lo innervosisce quando non lo annoia, è una bottiglia che appare rotta, destinata ad affondare senza recapitare il messaggio, o almeno senza recapitarlo a me.